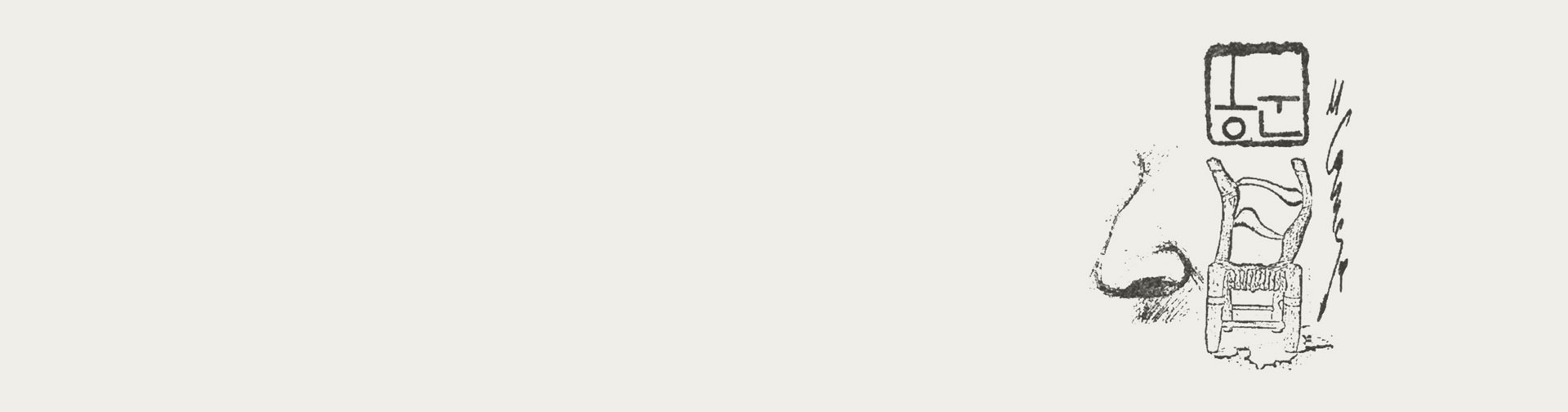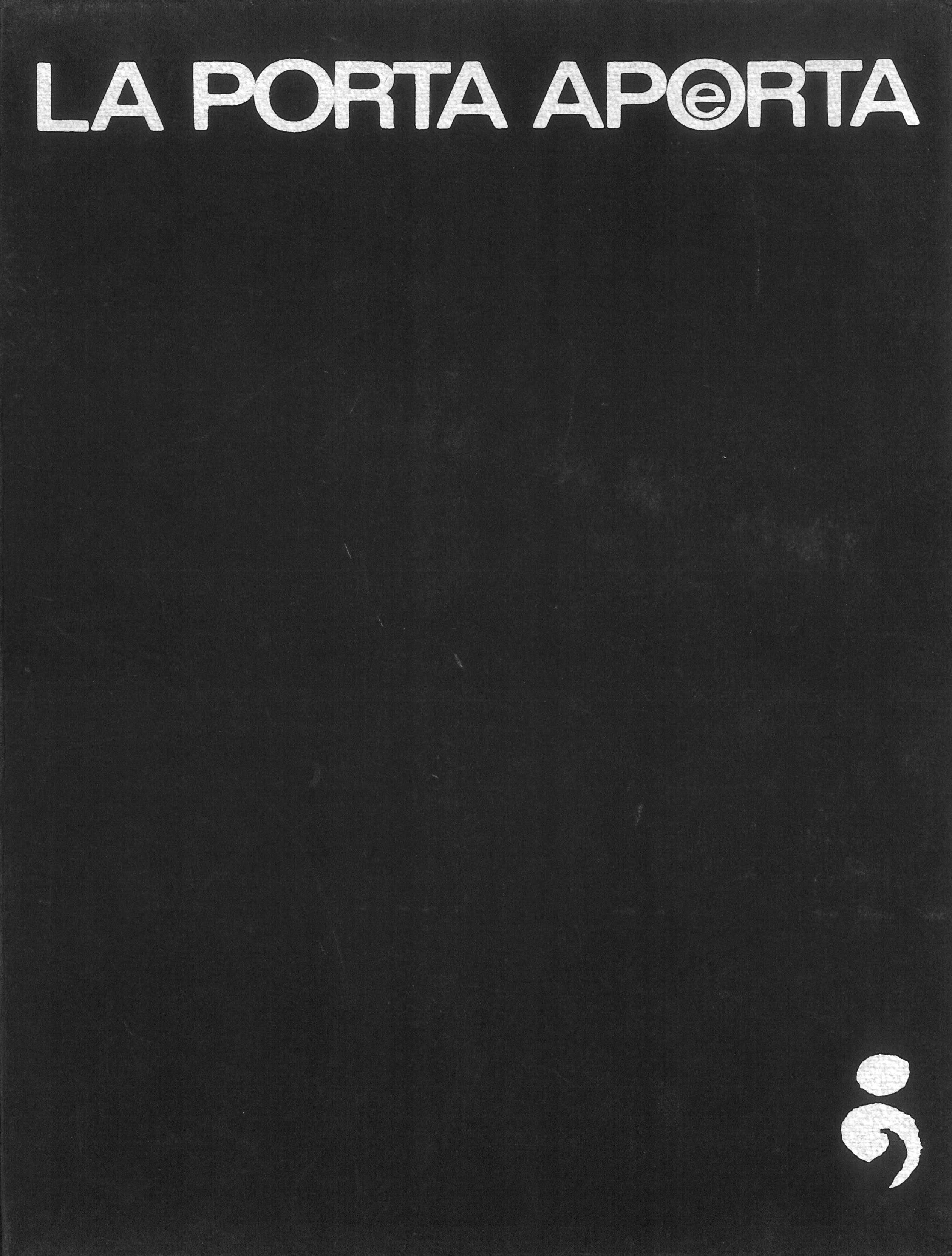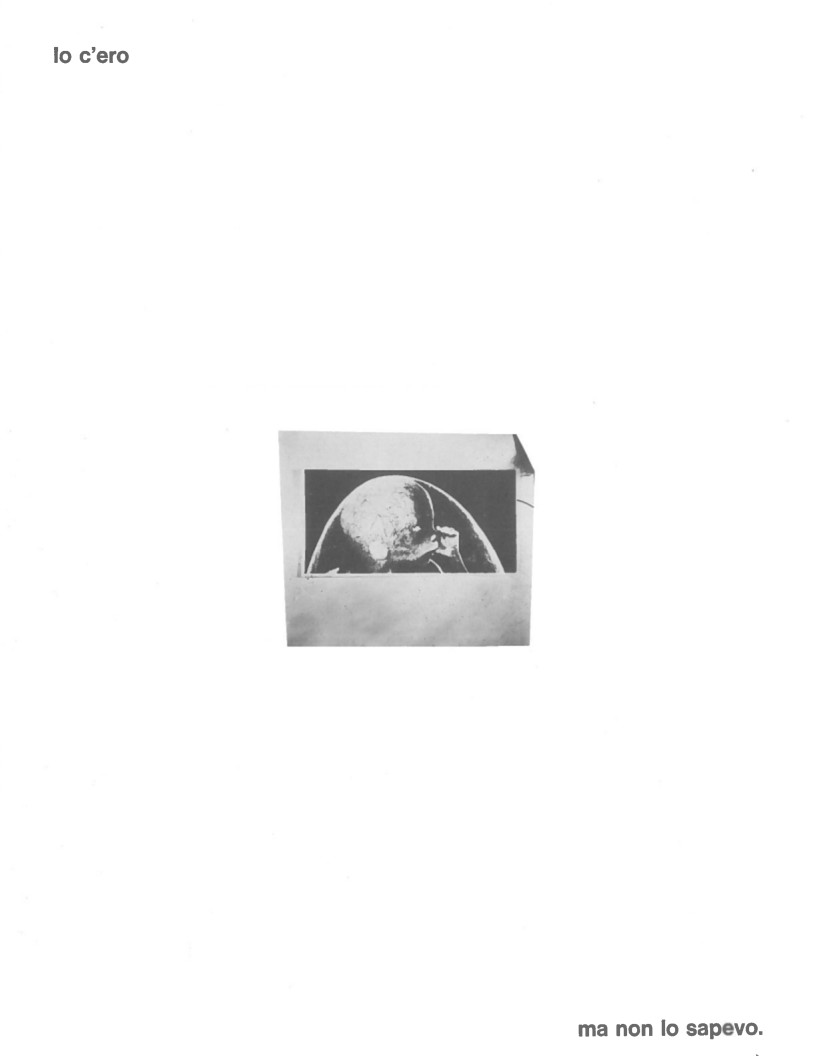04 Mar Ricerche interlinguistiche (1971)// Testo di Ugo Carrega
Quali sono i limiti del linguaggio?
I limiti del linguaggio orale sono i limiti della gola del corpo.
Su tutto, i limiti della convenzione sociale.
Per dire “ho mal di pancia” un bimbo piange mugola si sfrega il ventre. Un adulto dice “ho mal di pancia” ed intanto sorride (eroicamente).
I limiti del linguaggio scritto li sappiamo tutti: non potremo mai annotare i toni della voce i gesti della mano che si legano al significato della parola in modo inscindibile.
Pensiamo alla parola amore: sussurrata blaterata frascheggiata detta accennata rintuzzata esclamata affermata fra mille toni squitìi e intanto le mani?
Per annotare tutto questo, mille parole pesanti inutili (fare all’amore non è descriverlo et viceversa).
Si pensi ad “ah” (a + h): ogni modo di dirlo è annotabile così: ah, – ah; – ah! – ah? – ah. Ma provatevi a descrivervi il tono le sfumature vi troverete in pieno fumetto. Ma i sentimenti sono solo fumetto?
D’altronde la parola scritta ha vantaggi sull’orale: ha meno possibilità di confronto con la verità ed ha più durata nel tempo.
Per entrare in una stanza prima apro la porta e poi entro. Se dico “entro e apro la porta” e intanto eseguo sbatto il naso contro la realtà e non c’è cavolo che tenga.
Ma se lo scrivo, faccio letteratura (ed ecco perché tanti politici a mio avviso ce l’hanno con la letteratura: due parole scritte possono a volte mettere in crisi una realtà).
Dunque: la scrittura simbiotica si occupa dei valori connotativi del linguaggio, quei valori contenutistico-formali che necessitano molte parole per essere descritti e che la scrittura simbiotica cerca di recuperare sinteticamente (con processo tipico della poesia).
(Scrivere la stessa parola in cento modi diversi è dare cento modi diversi dello stesso concetto affermando un processo del linguaggio, il flusso).
È così che si giunge all’idea della pagina come nuovo mezzo di comunicazione scritta: nasce una nuova idea di grammatica e di sintassi come “far stare assieme segni di linguaggi diversi”.
Sulla pagina agiscono centinaia di segni diversi (basta osservare una qualsiasi pagina stampata, di quotidiano, di rivista), legati tutti da un filo di significato.
Scrittura simbiotica: scrittura come “la mano lascia un segno sulla pagina”; simbiotica come “interazione con reciproca utilità di due o più organismi linguistici”.
Si cerca in definitiva di stimolare un linguaggio che non si preoccupi molto di descrivere un al di là da sé, ma che si preoccupi invece di mettere in evidenza il proprio processo, il proprio farsi, il divenire, di essere presente in quanto lui medesimo così cone è.
E da questa idea di nuova scrittura, nasce l’idea di un nuovo linguaggio orale che si arricchisce di tutti quegli elementi (cinesica e paralinguistica) che ne arricchiscono i significati mediante tutte quelle connotazioni ritenute non-linguaggio (idea della comunicazione simbiotica). E nello stesso tempo ci si accorge che non è necessario scrivere solo sulla carta. Ci si accorge che qualsiasi supporto può reggere una scrittura ad aiutarla nel rivelarsi.
Nasce così l’idea che tutto è “linguaggio” e che “è l’uso del linguaggio” a far poesia, musica, pittura perché il linguaggio in sé è inerte.
È così necessario operare, formulare dei “discorsi” con il linguaggio che si è scelto per dargli una prospettiva storica (idea della poesia materica).
U. Carrega, La porta apo(e)rta, Pollenza (MC), La Nuova Foglio Editrice, «Altro», [1971].